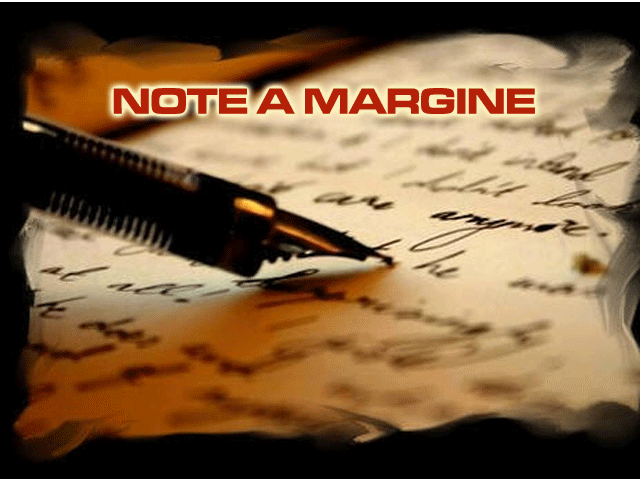Ovvero…Obama: il dominio dell’apparenza sulla sostanza.
Quando Obama si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti la considerazione che il mondo aveva degli USA era ai minimi storici, serviva inderogabilmente una svolta per riprendersi e restare saldamente al timone del mondo; servivano una buona campagna promozionale (….ops non doveva essere una campagna elettorale?) e un testimonial (cioè Presidente) abbastanza giovane e alla moda per riuscire a competere nel difficile mercato del momento.
Il testimonial è stato trovato in Barack Obama, un uomo dotato di un istinto naturale per il marketing, che si è circondato di una squadra di grandi esperti di pubblicità. Come coordinatore della sua campagna elettorale sui social network ha scelto Chris Hughes, uno dei fondatori di Facebook e il suo principale consigliere è stato David Axelrod, socio della Ask Public Strategies, società di pubbliche relazioni che ha organizzato le campagne pubblicitarie di alcuni tra i più famosi marchi mondiali. Questa squadra di consulenti ha sfruttato tutte le risorse del moderno arsenale del marketing per lanciare e far crescere il marchio Obama: un logo perfettamente calibrato (un sole che sorge sopra la bandiera a stelle e strisce), un uso attento del marketing virtuale (suonerie a tema Obama), il product placament (piazzare gli spot nei posti giusti com’è stato fatto nei videogiochi), alleanze strategiche con altri marchi: Oprah Winfrey per ampliare al massimo il bacino d’ascolto, la famiglia Kennedy per darsi un tono serio e un folto gruppetto di star dell’hip-hop per costruirsi un’immagine al passo con i tempi. L’operazione è riuscita al punto che, poche settimane prima di vincere le elezioni, Obama si è aggiudicato il premio dell’Associazione nazionale dei pubblicitari battendo aziende del calibro di Nike ed Apple. Secondo la rivista Portfolio, inoltre, a febbraio 2009 la “Obama economy”, il turismo generato dal Presidente e i gudget a lui ispirati, valeva 2,5 miliardi di dollari, non male in piena crisi economica.
Bush aveva usato il suo ranch di Crawford, in Texas, come fondale per la sua personalissima interpretazione di Malboro Man, che passa il tempo a cavalcare, sfrondare cespugli e a preparare barbecue con gli stivali da cowboy ai piedi; Obama si è spinto molto più in là, trasformando la Casa Bianca in una specie di reality show senza fine che ha per protagonista l’adorabile clan Obama.
Il problema non è che Obama usi gli stessi trucchi dei grandi marchi, anche se, torno a ripetere, si sta parlando della campagna elettorale di chi attualmente, piaccia o non piaccia, ha in mano le redini del mondo, il problema è che si è poi fermato alla pura campagna pubblicitaria, non dimostrandosi assolutamente all’altezza delle aspettative, preferendo sempre e di gran lunga il gesto simbolico grandioso al cambiamento strutturale profondo. Annuncia a gran voce che chiuderà Guantanamo e intanto da il via libera all’ampliamento del carcere di Bagram in Afghanistan e si oppone ai processi contro i funzionari di Bush che autorizzarono le torture. Investe nell’energia pulita e rifiuta di tassare le emissioni di CO2, si scaglia contro l’avidità dei banchieri ma affida le redini dell’economia ai veterani di Wall Street e, quel che è peggio, promette di mettere fine alla guerra in Iraq, mandando in pensione l’orrendo concetto di “guerra al terrore”, mentre in Afghanistan e Pakistan i conflitti ispirati da quella logica si intensificano.
Obama è stato eletto in un momento cruciale. Nei due mesi precedenti le elezioni la colpa della crisi finanziaria che scuoteva i mercati mondiali veniva giustamente attribuita non solo alle cattive scommesse di Wall Street, ma all’intero modello economico di deregolamentazione e privatizzazione che era stato osannato da istituzioni controllate dagli Stati Uniti come il Fondo Monetario Internazionale e il WTO. Se gli Stati Uniti non fossero stati governati da una superstar internazionale il loro prestigio sarebbe crollato a picco e la rabbia nei confronti del modello economico responsabile della crisi globale si sarebbe probabilmente trasformata nella pressante richiesta di nuove regole per imbrigliare e, finalmente, tassare veramente la finanza speculativa. Quelle regole dovevano essere approvate durante il G20 a Londra nell’aprile del 2009, invece, mentre i giornali erano impegnati a riferire gli avvistamenti della coppia Obama, i leader mondiali si mettevano d’accordo per tirare fuori dalla crisi il Fondo Monetario Internazionale, uno dei principali colpevoli di quei guai, con finanziamenti per quasi mille miliardi di dollari. In altre parole, ancora prima delle elezioni, il marchio Obama stava non solo restaurando l’immagine degli Usa ma ha anche resuscitato il progetto economico neo liberista che aveva già un piede nella fossa.
Questa predilezione per i simboli, a scapito della sostanza, e la riluttanza a tenere fede ad un’etica cristallina quando questa comporta scelte impopolari, allontanano Obama dai movimenti politici rivoluzionari cui tanto diceva di ispirarsi. Le richieste di quei movimenti erano molto chiare come l’aumento dei salari e programmi sociali ambiziosi, richieste che avevano di conseguenza nemici agguerriti. Obama di fronte a ciò segue ancora una volta la politica del marketing: offre uno schermo invitante su cui ognuno è chiamato a proiettare i suoi desideri più profondi, e lo fa in modo abbastanza vago da non lasciare indietro nessuno. Advertising Age aveva regione quando scriveva che “il marchio Obama è grande abbastanza da poter rappresentare qualunque cosa ma anche abbastanza personale da guadagnarsi il sostegno di chiunque” e inoltre “Obama è riuscito, chissà come, ad essere sia un Coca-Cola, sia una tisana naturale: è un megamarchio conosciuto e distribuito in tutto il mondo e allo stesso tempo un outsider che si è fatto da solo”.
In altri termini Obama ha interpretato il ruolo di guastafeste pacifista e nemico di Wall Street agli occhi della sua base. L’ha fatta sentire protagonista di una rivolta contro il monopolio politico dei due grandi partiti americani condotta grazie ad un’organizzazione perfetta a colpi di donazioni raccolte vendendo limonata e racimolando i soldi tra i cuscini del divano. Contemporaneamente ha preso più soldi da Wall Street di qualunque altro candidato alla presidenza. Nonostante tutto ciò, dopo 12 mesi dalla sua elezione, anche se ormai era già chiaro agli occhi del mondo che, almeno in politica estera, Obama stava proseguendo sulla linea di Bush (con uno stile meno arrogante), in Giordania e in Egitto la percentuale di consensi era quattro volte superiore a quella dell’era Bush; in Europa l’inversione di rotta era drastica: il 91% dei francesi e l’86% dei britannici aveva fiducia nelle scelte di Obama, rispetto al 13 e 16 dell’era di Bush. Secondo Usa Today il sondaggio dimostrava che “Obama ha restituito credibilità all’immagine degli Stati Uniti dopo otto anni di amministrazione Bush”. Secondo David Axelrod era successa una cosa molto semplice: l’antiamericanismo non andava più di moda. Insomma campagna di marketing perfettamente riuscita, cosa che non dovrebbe stupire nessuno se si tiene presente che proprio dall’America è partito il dominio dell’economia virtuale su quella reale e della finanza sull’economia con le conseguenze che tutti conosciamo e tutti stiamo pagando; in fin dei conti se il boomerang del virtuale rispetto al reale è tornato al mittente non solo non ci stupiamo ma non ce ne dispiacciamo neanche più di tanto.
Raffaella
 Progetto Nazionale Verona Sito Ufficiale – Progetto Nazionale Verona
Progetto Nazionale Verona Sito Ufficiale – Progetto Nazionale Verona