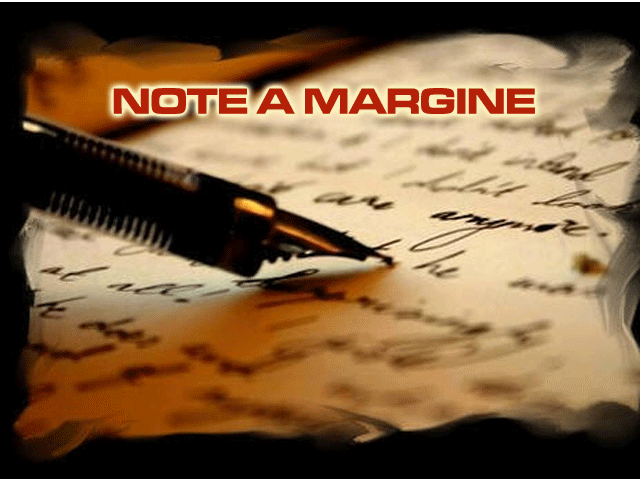Proponiamo in questo spazio un estratto dall’opuscolo “Lo stile del militante” (Quaderni di Formazione Politica); si tratta della seconda parte del quaderno, firmata da Rodolfo Sideri, docente di Storia e Filosofia e saggista, già autore degli ottimi “Inquieto Novecento” e “Strade d’Europa”, entrambi usciti per i tipi della Settimo Sigillo ed entrambi scritti a quattro mani con Mario Michele Merlino.
Lo scritto di Sideri qui considerato, è stato realizzato come contributo per la formazione politica dei militanti del partito La Destra e si concentra sul tema dell’Identità: lo riteniamo meritevole d’esser letto, meditato, metabolizzato.
Per l’intera lettura del quaderno rimandiamo invece al sito www.adrianotilgher.it, nell’area Download/Scuola di Formazione Politica Beppe Niccolai. Proprio Tilgher è l’altro coautore del quaderno, col brano “Lo stile del militante”.
Buona lettura.
IDENTITÀ E STILE
di Rodolfo Sideri
Sul principio di identità e non contraddizione il mondo occidentale, da Aristotele in poi, ha costruito su solide fondamenta. Ha costruito la visione greca della vita, una visione della vita agonistica, qualitativa, eroica e trascendente che ha illuminato il successivo mondo romano e medioevale, mentre il suo crepuscolo rendeva ancora capace l’Europa moderna di conquistare il mondo. Oggi, calate le ombre della sera, l’identità spaventa; essa viola infatti i santuari del politicamente corretto, espone, chi la rivendica, all’accusa di arroccamento o di estremismo. Oggi, dicono i filosofi, viviamo una liquid modernity e ciò significa che se si vuole vivere accettando il proprio tempo, accettati dal proprio tempo, occorre diventare liquidi appunto, indeterminati, privi di una reale e solida sostanza. Questa liquidità in politica si chiama trasformismo, nella sessualità travestitismo, nella vita di tutti i giorni opportunismo. Non a caso si tratta di categorie che i nostri tristi tempi tengono sempre più in onore. Chi invece rivendica un’identità, chi si sente identitario, si pone come una realtà corposa dinanzi a una realtà sempre più sfumata e sfuggente, irreale e virtuale. Perché la modernità, come diceva Georg Simmel, è l’epoca che tende a fuggire ogni forma e quindi ogni disciplina. Parlare di identità spaventa anche perché la nostra società rifiuta il confitto, rifiuta cioè l’idea che il confitto possa essere, e a volte debba essere, un momento e una possibilità dell’esistenza e quindi tende a rifiutare ogni identità per non essere identificata da qualcuno, inevitabilmente, come avversaria o nemica. Senza rendersi conto che in questo modo rende impossibile quel dialogo cui tanto anela, perché non ha più nulla da dire, non essendo più nulla. Cancellare i segni della propria storia, delle proprie tradizioni – cioè della propria tradizione – significa mostrare che essi non hanno più valore per noi o che siamo disposti a rinunciarvi. Illusorio credere poi alla possibilità di un’intesa o addirittura di un’integrazione: per integrare occorre poter far riferimento a un nucleo comune che noi per primi dimostriamo di disprezzare, avendo ridotto l’uomo a una cifra puramente edonistica e consumistica. Il giusto atteggiamento ce lo insegna l’imperatore Federico II che riconquistò pacificamente Gerusalemme grazie alla conoscenza del mondo islamico e della stima di cui godeva presso il sultano Al Kamil. Si narra che dopo aver soggiornato nella città santa, al risveglio, un mattino, Federico chiedesse al cadì perché non avesse ascoltato di notte la preghiera del muezzin. Il cadì rispose che il sultano aveva dato ordine di sospendere il richiamo per un gesto di cortesia e rispetto per lui. Federico rimproverò il cadì: se il sultano fosse venuto a trovarlo non avrebbe ordinato alle campane di non suonare per chiamare a raccolta i fedeli. Splendido episodio che dimostra cosa debba intendersi per liberalità: rispetto verso le usanze altrui, ma in casa propria diritto di dettare le regole.
L’identità, presupponendo l’alterità, crea la diversità, non teme ma esalta le differenze; è solo l’identità che consente di mantenere un orientamento verticale della vita, rifiutando la reductio ad bestiam. Perché gli uomini sono tutti uguali solo se visti come animali: tutti mangiamo, tutti respi-
riamo, tutti svolgiamo allo stesso modo le funzioni fisiologiche. Appena lo sguardo si eleva a una dimensione superiore, spirituale, gli uomini appaiono tutti differenti. E per il principio degli opposti, la diversità ci rimanda all’unità, all’identità.
Ma che significa identità e identitario? Come diceva sant’Agostino a proposito del tempo, l’identità è qualcosa che ognuno sa cos’è e poi, quando si va a definirla nessuno lo sa più. Per identità si può intendere una visione del mondo che nasce da un comune radicamento culturale, sentimentale, psicologico e comportamentale originato da una storia comune. In altre parole, l’identità è l’espressione simbolica dei rapporti che legano un gruppo sociale e un gruppo sociale legato da questi rapporti non può che essere una comunità. Identità non è infatti individualismo, quanto piuttosto comunitarismo; la mia identità rimanda infatti ad altri e ad altro nei confronti del quale sono identico. Dire identità significa dire comunità, cioè un gruppo umano che si sente disponibile alla condivisione di un comune destino. Oggi si vuole che la comunità lasci il posto alla società civile che già Hegel definiva il luogo della libera conflittualità economica, della guerra di tutti contro tutti in nome del proprio tornaconto.
La società civile è infatti funzionale al progetto di riduzione dell’uomo ad atomo privo di radici, esposto a ogni determinazione esterna e legato agli altri solo dall’utile economico. La comunità non lo consente perché concepisce l’uomo come parte organica di un tessuto vivente. La società è il luogo dei diritti individuali, concepiti e vissuti in modo anarchico e distruttivo. La comunità è il luogo dove i diritti diventano doveri verso gli altri, dove il centro è il bene comune la cui pratica rinsalda il senso d’identità. La comunità è il lavoro vissuto quotidianamente come elevazione spirituale e realizzazione di se stessi, come contributo alla costruzione di un percorso comune. Si è tanto ironizzato su quella celebre espressione del Ventennio secondo la quale la Patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina, eppure, nella sua semplicità, indicava proprio che quando si vive in comunità, si è cellule di un organismo vivo e le cellule sono certo altamente differenziate e specializzate, ma hanno tutte pari dignità e importanza nel momento in cui concorrono alla vita del tutto. Nella società il lavoro non è servizio, ma un semplice strumento di guadagno a sua volta considerato solo in funzione di un consumo edonistico, cercato e perseguito in modo bulimico nell’illusione che possa compensare la mancanza di identità, e per il resto si lavora meno che si può, peggio che si può. Privata dell’identità, la società è continuamente stesa sul lettino dell’analista a raccontare le sue nevrosi senza cura, le sue patologie senza speranza perché frutto del nulla in cui è sprofondata avendo rifiutato l’identità. La comunità è invece il luogo dove l’individuo sa e può definirsi, dove il lavoro è servizio, in qualche modo amore e come ogni vero amore essenzialmente disinteressato.
La nostra società è il luogo del disagio, dove si sperimenta l’impotenza e la debolezza dell’uomo, dinanzi alle quali anche l’onnipotente tecnologia non può nulla. Perché l’uomo moderno è solo. Rinunciando per timore della conflittualità alla propria identità, si è consegnato a un relativismo assoluto che destabilizza tutte le strutture in cui l’uomo è naturalmente da sempre inserito: la politica, la famiglia, la cultura. La precarietà, nel lavoro come nella psiche umana, diventa la cifra caratterizzante il nostro tempo, da cui derivano affanno, insicurezza, frustrazione, ribellismo nevrotico e fine a se stesso. Tutto questo mentre la vulgata, specie nelle scuole, ci presenta il mondo tradizionale come un mondo chiuso, ingiusto e arretrato, ignorando che il rispetto delle gerarchie naturali e spirituali, l’ordinato compimento della propria vita e del proprio lavoro erano fonte di rassicurazione e di certezze. Il mondo che ha rifiutato la Tradizione, il nostro, è il mondo che ha gettato l’uomo nell’isolamento, lo ha lasciato solo dinanzi alle sue pulsioni, al suo egoismo, alla sua inerzia spirituale. È inevitabile, per parafrasare Goya, che il sonno della Tradizione generi mostri, mostri che la nostra società ha creato, ma dinanzi ai quali si spaventa, evoca dure repressioni. La nostra società è molto più repressiva, nonostante le dichiarazioni di principio, rispetto a quelle del passato, poiché quest’ultime offrivano all’uomo un appiglio, una direzione, una disciplina con le quali l’uomo trascendeva la propria miseria, utilizzava i propri istinti per il raggiungimento di alte mete spirituali. Le società tradizionali inserivano l’uomo in un ordine che lo trascendeva ed assicuravano a tutti un senso alla propria esistenza; né era impossibile un cambiamento di ruolo, ma questo doveva corrispondere a un’effettiva dimensione interiore e non essere una semplice pretesa, il più delle volte assolutamente immotivata. Invece la modernità inizia con quella rivoluzione astronomica che toglie l’uomo dal centro dell’universo e ne fa un ridicolo infinitesimo perduto nella vastità buia del cosmo. Prosegue con Darwin a dichiarare, se non a dimostrare, che siamo solo un’evoluzione scimmiesca e si conclude con Freud che riduce l’uomo a libido, alle pulsioni sessuali dell’Es. Era conseguente e inevitabile che si negasse il divino, cioè la trascendenza comunque la vogliamo declinare, si negasse ogni disciplina dello spirito, ogni verticalità. La vita dell’uomo doveva svolgersi su di un piano di assoluta orizzontalità, senza gerarchie; una vita spesa in un benessere bovinamente inteso, in attesa della morte, ora sì autentica nientificazione e quindi terrorizzante. Chi rivendica con orgoglio il senso d’identità, invece, non teme il sacrificio, sa disprezzare i commoda, sa sorridere alla vita senza paura della morte perché sa che, al di là di considerazioni fideistiche, ciò che ha fatto con amore sarà a sua vera eredità, per parafrasare Ezra Pound. Chi rivendica il senso d’identità aspira ad essere, come diceva Meister Eckart, il cardine che resta fermo anche quando la porta sbatte. Rivendicare la propria identità, il proprio essere identitario non è infatti una vuota petizione di principio, utile magari a nascondere le tante piccole viltà e pigrizie della nostra vita quotidiana. Certo l’identità non è neanche cultura in senso accademico. La Tradizione non si studia sui libri, non si insegna e non si impara: si sente di appartenervi oppure no. Intendiamoci, i libri e la cultura non sono poco importanti, servono ad innalzare a un livello di consapevolezza razionale questo sentimento d’appartenenza e prepararsi a quella battaglia delle idee e delle parole che il nostro ambiente ha finora sempre perso, lasciando che temi naturaliter di destra, come l’ecologismo, l’antimondialismo, finissero per essere appannaggio di altri, lasciando che persino la nostra storia, la nostra spesso sanguinosa e dolorosa storia, venisse descritta da altri. La battaglia culturale è importante perché la vulgata di sinistra presenta ancora il nostro ambiente come incolto, nel senso proprio di non coltivato intellettualmente, quando invece le massime intelligenze del Novecento sono parte integrante della nostra storia. La cultura è importante perché quando Dio diede ad Adamo il potere sugli animali, questo potere si configurò come diritto a dare ad essi il nome. Se lasciamo che altri “diano il nome” alla nostra storia, al nostro esserci, siamo già stati battuti. La cultura è importante dunque, ma l’identità, la Tradizione è essenzialmente stile di vita, per questo non ammette infingimenti, per questo l’ipocrisia, la separazione tra ciò che si dice e ciò che si fa, è per noi un peccato tanto più grave che per altri. Lo stile di vita che caratterizza la nostra identità è uno stile asciutto, non teatrale, uno stile che in un’epoca di istinti bassi e vili reclama energia, temerarietà, intrepidezza, quelle che Marinetti chiamava «le belle idee per le quali si muore». Uno stile antiborghese sempre, come diceva Brasillach. Per questo culturalmente siamo distanti da ogni forma di Illuminismo, perché lo stile, la forma per noi, precede l’idea. Pretendere di sottoporre il comportamento al calcolo della ragione – come volevano sostanzialmente gli Illuministi – significa ridurre l’esistenza a un dato quantitativo e misurabile, ché altrimenti non sarebbe possibile nessun calcolo. E calcolare la vita come fatto quantitativo non può che far emergere la dittatura della materia e dell’utilitarismo – non importa qui se pubblico o privato – su cui si fonda l’etica odierna. In realtà è la ragione che deve conformarsi allo stile di vita, a quella forma disciplinata dell’esistenza che stiamo descrivendo e regolare gli atti dell’esistenza su quella misura. Noi non abbiamo una morale universale, una morale buona per tutti gli usi. Come scriveva Mohler: «ciò che diventa morale è l’impegno singolo – sfida lanciata al caos». Sfidare il caos del mondo moderno è possibile adottando uno stile severo, in primo luogo verso se stessi. Perché le mollezze addormentano l’ideale e niente lo risveglia meglio e di più della sferza della vita dura. D’altronde, come diceva Degrelle, non siamo sulla terra per mangiare in orario, dormire a tempo opportuno, vivere cent’anni e oltre. L’unica cosa che conta è non vergognarsi della propria vita quando dovrà essere restituita e per questo dobbiamo affinare la nostra anima. È dall’anima che occorre ripartire, se ne saremo capaci. Questa è la grande rivoluzione da compiere, la rivoluzione spirituale. E per compierla occorrono anime che credono, che non esitano dinanzi allo sforzo, che sanno dominare i bisogni materiali. Al termine di queste battaglie si sarà conquistata la grandezza, che consiste nella nobiltà dell’anima che si adopera per ciascuno dei suoi doveri. La grandezza è compiere con la massima nobiltà mille piccole cose spossanti, superando orgoglio e pigrizia. La grandezza, in altre parole, è sapersi donare; gli insoddisfatti che si lamentano sempre, che non si rallegrano mai di nulla, trovano tutto noioso perché non si donano mai, perché si limitano all’indispensabile e anche questo a malincuore.
Lo stile non è riducibile a un decalogo, perché non è passività, meccanismo, ma un processo dello spirito e come tale sempre diverso nella sua articolazione, perché i tempi e le situazioni sono diversi; lo spirito è sempre vivente e non si può fissare in leggi immutabili. Ciò non toglie che siano possibili sintesi di un percorso che, diverso nelle sue declinazioni, è sempre lo stesso nel suo paradigma. Perché queste sintesi siano efficaci occorrono grandi spiriti; tra questi era certamente Arnaldo Mussolini che in “Coscienza e dovere” stilava il Decalogo dell’italiano nuovo che è utile, ancora, meditare. Al primo punto vi è l’affermazione che non vi siano privilegi, anzi che ce n’è uno solo: compiere per primi la fatica e il dovere. Essere cioè sempre davanti, ma non per essere i primi ad arraffare beni, sistemare parenti e rafforzare clientele, quanto per servire quella comunità di cui si è parte e che, come si è detto, sostanzia la nostra identità e il nostro essere. Essere sempre davanti agli altri per servire gli altri inaugura quella nobile gara che migliora i partecipanti, indipendentemente dall’ordine d’arrivo. Al secondo punto vi è accettare tutte le responsabilità e comprendere tutti gli eroismi. Responsabilità viene da respondere, rispondere cioè a tutte le chiamate del dovere e per questo si associa all’eroismo; le responsabilità non rimandano a nomine e prebende, ma a tutti quegli eroismi necessari per portare a compimento il dovere. Il terzo punto richiama la necessità di essere intransigenti, fermi al proprio posto di dovere e di lavoro; egualmente capaci di obbedire e comandare. Intransigenti essenzialmente verso se stessi, perché come diceva san Paolo: se anche gli altri io no. Solo così – se si sa obbedire a se stessi – si ha la legittimità di comandare, se a questo saremo chiamati. Il quarto punto affida il militante di una nuova vita al suo tutore, al suo giudice più consapevole, severo e inesorabile: la propria coscienza. Ad essa non si può mentire, per questo gli ipocriti, i sepolcri imbiancati, la fanno tacere. Al quinto punto la fondamentalità della fede, del volere il bene e operare in silenzio. Senza la fede è inevitabile lo scetticismo, il dubbio negatore, il chi me lo fa fare, che spinge prima o poi – più prima che poi – a barattare l’impegno con la ricompensa. Proprio a questo si rapporta il sesto punto, rammentando che la ricchezza è sì un mezzo necessario, ma insufficiente a creare forme di civiltà se non si affermano quegli alti ideali che sono essenza e ragione profonda della vita umana. Chiunque ha realizzato nuove forme di vita – siano queste figli, libri, prodotti del lavoro manuale, movimenti politici – conosce la gioia della creazione, quella gioia che chi si è consegnato al denaro come ragione di vita non ha mai provato, né potrà. Il settimo punto ricorda di non indulgere al mal costume delle piccole transazioni, perché chi accetta il compromesso si pone su un piano inclinato sul quale rischia di precipitare. L’ottavo punto invita ad accostarsi agli umili con intelletto d’amore, ovvero usare la propria consapevolezza, il proprio sapere, per elevarli a una più alta visione morale. Per questo, non c’è altro modo che essere un esempio di quella più alta vita politica e morale che non basta predicare. Prima di predicare agli altri – ci ricorda il nono punto – bisogna agire su se stessi: la vera retorica è l’azione, è l’esempio, non la frase ad effetto o l’espressione ricercata. L’ultimo punto del decalogo arnaldiano impone di sdegnare le vicende mediocri e di non cadere mai nella volgarità. Abbiamo così tutta la distanza che separa lo stile di un militante dai canoni esistenziali dell’oggi, in cui la mediocrità e la volgarità hanno invaso tutti gli interstizi del vivere sociale, diventando essi i canoni di misura e gli strumenti stessi del successo. Questo stile, ribadiamo, non ha nulla a che fare con l’individualismo, anzi ne è l’opposto. L’individualismo è lo stile borghese, in cui l’individuo, nell’illusione di potersi staccare dalle sue radici, vive limitato nella dimensione edonistica ed egoistica che ben connota i nostri tempi. L’impegno individuale a uno stile severo, senza cedimenti verso se stessi, è ciò che rende possibile una comunità e non un semplice aggregato di uomini. Perché non c’è comunità senza disciplina interiore, senza un rigido rispetto delle regole liberamente accettate, senza fedeltà alle gerarchie liberamente formate. E disciplina, rispetto delle regole senza compromessi, fedeltà sono possibili solo in uno stile severo di vita.
Questo stile di vita si alimenta al mito. Il mito non è una favola, è l’espressione simbolica di un sentire, l’aura poetica che illumina un percorso e indica una meta. Il mito più forte è stato per noi l’Europa. Non quest’Europa di mercanti e di banche, di finanza e moneta unica, che ha saputo partorire soltanto un’elefantiaca e ottusa burocrazia, un ampliamento del mercato e una restrizione delle libertà, tanta demagogia e nessuna idea, una bandiera brutta perché priva di un’anima, perché nessuno ha versato il suo sangue per essa e, come diceva Drieu La Rochelle, nulla di grande si compie senza il sangue. Una bandiera che gli edifici pubblici hanno l’obbligo d’esporre, ma che nessuno si sognerebbe di sventolare per le strade, anche perché non ne ha nessuna occasione. Non è neanche l’Europa di un trattato gabellato da costituzione, imposto ai popoli dalle oligarchie politico-economiche, padrone di questa Europa. L’Europa che ispira la nostra identità è un mito che sprigiona una potenza etico-allegorica. Non è l’evocazione di un fantasma, ma di una forza, una forza che ha attraversato la storia dalla comunità combattente degli Spartiati alla disperata e vittoriosa difesa delle proprie tradizioni della Vandea contro la ferocia razionalistica della rivoluzione francese; dalla conquista dell’oriente da parte dei Cavalieri Teutonici alla difesa del nostro Continente dal consumismo americano e dal materialismo comunista in quella Berlino in cui Adriano Romualdi ha visto consumarsi le ultime ore dell’Europa. Possiamo, in conclusione, misurare quanto l’identità e uno stile di vita siano oggi rivoluzionari. Si può rimpiangere di vivere in tempi così lontani dal nostro sentire, ma possiamo anche ritenere che sia questa la nostra prova, la nostra battaglia, il nostro essere misurati con la più dura misura. Neppure dobbiamo peccare d’orgoglio e credere che la crisi che viviamo sia una novità, del tutto nostra. Come diceva già nel XIII secolo san Bernardo di Chiaravalle, «ogni tempo ha le sue notti e non sono poche».
In questa nostra notte, però, ognuno si senta impegnato ad essere quella mano che regge una fiaccola e che è il simbolo di questo partito.
 Progetto Nazionale Verona Sito Ufficiale – Progetto Nazionale Verona
Progetto Nazionale Verona Sito Ufficiale – Progetto Nazionale Verona